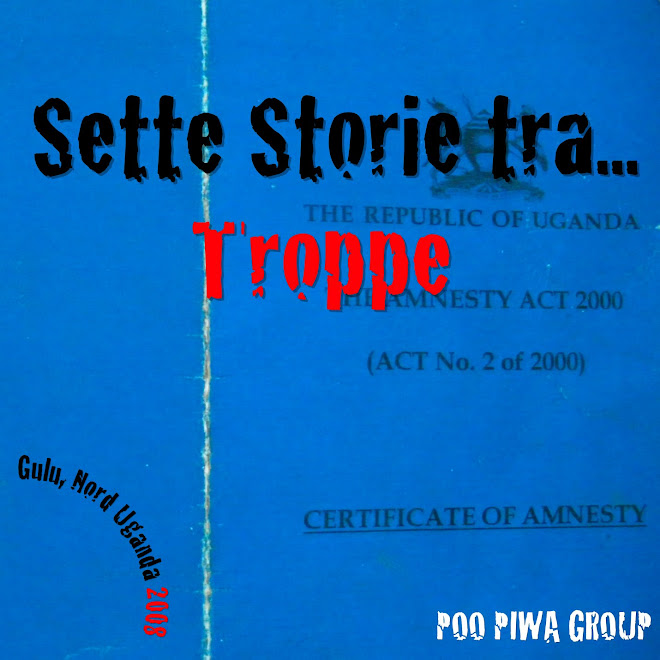La resilienza suscita un forte interesse e ha permesso agli educatori e pedagogisti interessati di disporre di una più ampia bibliografia, soprattutto in inglese e in francese. Attualmente la letteratura internazionale mostra come in molte parti del mondo, dal Cile all’India, da Taiwan alla Francia, dal Libano alla costa D’Avorio, dal Rwanda alla Bosnia Erzegovina, i temi connessi allo studio delle situazioni di alta vulnerabilità e alle possibili forme di aiuto, contemplano

il concetto di resilienza come uno dei fondamentali punti di vista dai quali procedere per favorire processi di reintegrazione. Le esperienze dei protagonisti, che da molti anni operano in zone di guerra sono state rilette e interpretate e hanno portato e hanno portato alla definizione di alcuni modelli applicativi. Sono sostanzialmente due: il modello francofono realizzato dal Bureau Catholique International de l’Enfance (BICE) di Ginevra, ovvero la Casita, e il modello anglosassone della Fondazione Bernard van Leer. Secondo Stefan Vanistendael (1994), responsabile del settore di ricerca e sviluppo e deputato del Segretariato Generale della BICE, la resilienza ha due componenti fondamentali:
- La resilienza alla distruzione e la possibilità di preservare l’integrità nonostante circostanze difficili
- la capacità di costruire positivamente la propria vita nonostante le situazioni difficili
La BICE ha cercato di elaborare una sintesi, un modello ad uso dei professionisti, utilizzata per la prima volta in Cile, ecco perché è stata chiamata “Casita (piccola casa) . Questo modello è utile a descrivere eventi e orientarsi.
La Casita è una sintesi di alcune tappe che, secondo Vanistendael, meritano un po’ di attenzione per coloro che desiderano costruire o rafforzare un processo di resilienza.
Ecco come è composta la Casita:
Il Suolo: corrisponde alla soddisfazione dei bisogni primari come l’alimentazione il sonno, protezione ecc.
Le Fondamenta: sono costituite dall’accettazione totale della persona ( nella misura possibile). E’ la possibilità di usufruire di contatti informali di una rete delle relazioni solidali (famiglia, amici e vicini ). È in buona sostanza un percorso di accoglienza.
Il Giardino: Qui si trova la capacità di scoprire un senso una coerenza del proprio percorso di vita. Lo si può fare attraverso il gioco, lo studio, il lavoro.
Il Primo piano: E’ in quest’area che si trovano la stima di sé, le attitudini le competenze l’humour. È la possibilità di progettare, di vedersi nel futuro. Aumenta la partecipazione e promuove la responsabilità del proprio agire e essere.
Il Granaio: Qui sono collocate tutte le altre esperienze da scoprire, a seconda del contesto .
Ecco in breve la casita, nel raccontare mi sono aiutato con un testo di Elena Malaguti, docente di Pedagogia Speciale all’Università di Bologna, “Educarsi alla Resilienza” (Erikson). Lo consiglio a chi volesse saperne di più sul concetto di resilienza.
Buon approfondimento
Gigo